
2007 // Modern Love
The Coldest Season
Deepchord presents Echospace
La musica è suono e il suono è fisica. Vibrazioni di molecole dell’atmosfera che si muovono e colpiscono il nostro timpano, ma anche la nostra pelle, le nostre ossa, i nostri muscoli, i nostri tessuti. Spesso le cuffie o l’altoparlante del cellulare ci fanno scordare la consistenza materica del suono.
The Coldest Season di Deepchord è costruito su questo principio: muri di suono grigi e impenetrabili da cui emergono barlumi e particolari a prima vista invisibili. Il suono è denso, una coltre pesante. L’aspetto più affascinante del disco è il continuo rumore bianco, il fischio di sottofondo del vento o della tormenta di neve, che fa da base a tutte le tracce e che avvolge il corpo in maniera fisica durante l’ascolto, come se si fosse immersi in una fitta nebbia. C’è un profondo piacere nell’interagire fisicamente con il suono, sentirlo attraversare il nostro corpo che vibra. Simon Reynolds descrive qualcosa di simile parlando dell’esperienza rave nel suo libro Futuromania: “La percezione retinica è eclissata dall’elemento audio-tattile, un continuum vibrazionale nel quale il suono è talmente amplificato da farsi viscerale. Questo orientamento nei confronti del suono è incarnato dai raver che abbracciano letteralmente gli altoparlanti, a volte infilandosi persino nella cavità del woofer per rannicchiarsi come un feto”. Sì, penso che l’idea di rannicchiarsi nella cavità di una cassa, vibrare con tutto il proprio corpo immerso in quel suono e in quella vibrazione mastodontici renda bene l’idea di quello che intendo. Come se fossimo ancora immersi nel liquido amniotico e le vibrazioni fossero tutto ciò che possiamo percepire. A me vengono i brividi solo al pensiero, con l’acufene che mi ritrovo, eppure la trovo un’immagine poetica.
Forse, però, dopo questa tiritera, sarebbe il caso di spendere qualche parolina sulle canzoni. Il duo formato da Rod Modell e Steven Hitchell sta dietro l’alias Deepchord presents Echospace. The Coldest Season è uscito ormai parecchi anni fa, nel 2007, e riprende la classica tradizione dub techno, ma virandola in una chiave più ambient, in una sorta di minimalismo rumoroso e granuloso. La componente dub, però, rimane fortissima e spesso anzi le tracce virano più verso di questa che verso la techno in senso stretto. Il disco è costruito su lunghe composizioni di strati di rumore sovrapposti, su cui si accendono e scompaiono riverberi ed echi. È uno studio sul riverbero in ogni sua forma, in ogni sua possibile texture e consistenza. Al di sotto, si accende e si spegne il basso che emerge dal rumore e si confonde nuovamente.
Il disco inizia con il suono del vento, rumore bianco che non ci lascerà mai. La prima traccia, First Point Of Aries, è lenta e cresce gradualmente, stendendo lunghi e cavernosi echi sul rumore, prima che parta il basso. La seconda traccia, Abraxas, si fa più complessa e quasi melodica. Ocean of Emptyness è l’essenza del disco: strati e strati di suono e rumore, lenti riverberi e drones che emergono svogliatamente e poco altro. Una superficie oscura di un lago che si increspa costantemente in modi sempre nuovi. Aequinotium è una canzone più classicamente dub techno: la batteria è dritta e precisa, ma a dominare è una linea melodica (se così si può dire) tagliente e – neanche a dirlo – affogata nel riverbero. Al di sotto un basso cupo e meditativo sostiene la traccia. Celestialis è eterea e spaziosa, con una batteria granulosa, ma accattivante. Elysian è costruita su un groove più veloce e trascinante, dritto e preciso, e una linea melodica che si sgretola e si frammenta o si attorciglia in volute di echi. Il disco termina con il contrasto di Empyrean, che si discosta dalle atmosfere precedenti. Il ritmo è ballabile e una melodia psichedelica si arrotola su se stessa: un’euforia contenuta percorre la traccia.
The Coldest Season è un esempio estremo di minimalismo, per quanto rumoroso possa essere. Eppure non stanca mai perché nella sua spaziosità e nei suoi infiniti livelli c’è sempre un particolare nuovo, sempre una sfumatura che non si era notata.
Nel corso di quest’anno ho sentito il bisogno di tornare a questo disco tante e tante volte: l’ho ascoltato nelle notti di agosto su un letto di un amico, cercando di trovare un senso a quello che stavo provando, oppure nella mia camera fino ad addormentarmi, mentre ero in pullman, con i suoni intorno a me che si confondevano con il disco, mentre giravo in domeniche freddissime per Torino. È un disco che mi culla e mi abbraccia, malinconico ma ritmico, che posso ignorare per lasciar correre i pensieri, o di cui posso seguirne il dipanarsi con attenzione.
Se vuoi ricevere una mail quando pubblico un nuovo articolo, c’è la newsletter.
Pubblicato il 27 Dicembre 2024
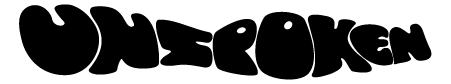




Scrivi un commento